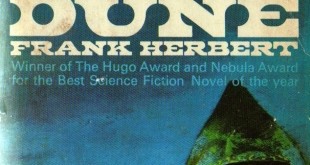Letter from an imaginary man (di Matilde de Feo, 41’, 2015): un inno corale per affermare che non “tutte le lettere d’amore sono ridicole”
Letter from an imaginary man (di Matilde de Feo, 41’, 2015): un inno corale per affermare che non “tutte le lettere d’amore sono ridicole”
Quando due anni fa in giuria alla XVII edizione del LFF ci siamo ritrovati davanti al lavoro della bravissima artista casertana, l’immediato richiamo letterario non è potuto essere che quello alle elaborazioni pessoane sul tema dell’amore; tema che è il cuore di cui questo film partecipato, nato inizialmente con vocazione video-performativa ma rapidamente trasformatosi in opera narrativa, risultato di una raccolta di storie e persone reclutate tramite un appello via web. Guardandolo e discutendone a fondo con i compagni di viaggio di quell’entusiasmante edizione, abbiamo scoperto che le lettere d’amore possono anche costituire un percorso intersoggettivo. E che a “essere ridicoli” sono non solo coloro che non ne hanno mai scritte (Álvaro de Campos), ma anche chi è fermamente convinto che esse siano da confinare in una rigorosa sfera intima e privata, senza mai condividerne il portato emotivo e artistico, e dunque fungere da canone d’ispirazione per chi è alla ricerca di modelli comunicativi, performativi.
In questi due anni, il documentario (www.letterfrom.it, prodotto da Mald’è e Giuseppe Beneduce in collaborazione con Marechiaro Film) ha partecipato a più di venti festival, portando a casa vari premi, tra cui quello alla miglior fotografia del #LLF2016 e, nello stesso anno, il Lisbon International Film Festival. Oggi rilancia la sua struttura “aperta e non lineare” in un nuovo percorso in collaborazione con l’artista Max Coppetta. Abbiamo dunque voluto scambiare due chiacchiere con la sua autrice, artista affermata nel panorama nazionale delle arti video-performative, reduce dal successo del suo racconto “in giallo” della città che ne accoglie l’estro creativo (clicca qui per il video) e attualmente impegnata, come detto, in nuovi progetti (www.malde.it/bio/matilde-de-feo/). Le abbiamo chiesto dove nasce quel lavoro e cosa vuole rappresentare, qual è il suo rapporto col documentario e, in generale, col lavoro cinematografico.
Un esperimento, quello di De Feo, che oggi (su modalità e temi diversi) prova a rivivere nel grande sforzo che lo staff del LFF e il grande regista Mohsen Makhmalbaf stanno portando avanti per regalare al pubblico della futura capitale europea della cultura (Matera2019) un racconto corale di una terra piena di storie e sentimenti.
Matilde, i riferimenti del tuo lavoro sono la musica contemporanea di Morton Feldman, e il cinema di Agnes Varda. Vuoi descriverci il percorso che ti ha portato a queste sottili fonti d’ispirazione?
Sono solo due riferimenti altissimi in un marasma molto più ampio di cose che mastico da sempre e che nutrono il mio immaginario.
La musica contemporanea come la pittura informale mi colpisce per il rigore dell’assenza, per la ricerca di una forma diversa, “Non c’è più nulla da dire eppure bisogna dirlo” come nella drammaturgia di Samuel Beckett, che è un altro “altissimo” sempre presente nella mia vita. Mi interessa molto la ricerca sulla forma, sui linguaggi, e l’urgenza comunicativa che si trasforma sempre in una scoperta.
Agnes Varda è un’artista che ha uno sguardo unico, la riconosci subito, non esiste un fotogramma uguale al suo nel mondo, un modo di raccontare le cose personalissimo che mi colpisce, la miglior frontiera del pionierismo cinematografo femminile con Chantal Akerman e Maya Deren. Trovo in questi riferimenti, in queste grandi madri, esattamente tutto quello che vorrei, poesia e ricerca, ironia e sperimentazione.
In occasione dell’uscita del tuo lavoro, nel 2016, hai dichiarato che il documentario (come modalità artistica) costituisce il tuo personale passaggio intermedio tra la videoarte e il cinema: bisogna dunque attendersi un passaggio ulteriore?
Il documentario è un genere cinematografico molto complesso, esiste un grande rigore e un integralismo che mi imbarazza pensando a un certo tipo di documentario e di documentarista. Io non penso a quello, ma piuttosto ai riferimenti di cui parlavamo prima, è la Varda che dice che la vita si mette in scena da sola, che bisogna solo osservare, ed è questo il documentario che mi interessa, che mi permette di sperimentare, cercare nella vita l’ispirazione, trasformare le storie reali in visioni. Non mi piace lavorare con gli attori, ho fatto l’attrice per più di dieci anni e smettere è stata una liberazione. I soggetti di un film, dal mio punto di vista, dovrebbero essere sempre liberi di muoversi nell’inquadratura con la propria identità, con gli abiti che hanno scelto di indossare la mattina. Solo attraverso questa verità si può raccontare qualcosa di coinvolgente per lo spettatore. Il passaggio al documentario non è senza ritorno, ma riconosco che è il più bel genere per un video artista, quello più coinvolgente perché ti costringe a osservare il mondo veramente e a fare delle scelte profonde. È un’operazione anche politica, c’è un senso di responsabilità rispetto alla realtà e ai soggetti reali. Anche per il museo Madre di Napoli abbiamo realizzato uno storytelling partecipato, una storia scritta con la partecipazione e complicità degli abitanti della città, a partire da una visione, l’invasione della ginestra Etnea. Siamo entrati nelle loro case per raccontare Napoli. Questo lavoro è sicuramente un’estensione di Letter from, un’evoluzione del mio lavoro che procede verso la transmedialità e la partecipazione.
Il tuo lavoro, al netto della performance audiovisuale che ci restituisce, si configura come una sorta di documento sull’archeologia della comunicazione?
È proprio sull’archeologia della comunicazione, sul concetto di obsolescenza che Letter from vive una nuova stagione distributiva e videoinstallativa. Dopo due anni di distribuzione tra sale e festival di cinema, il documentario soddisfa la sua vocazione di film non lineare e videoperformativo e sarà videoinstallato in forma di racconto espanso.
Per il Cyfest, il festival di arte e tecnologia più importante della Russia, per la prima volta in Italia alla Reggia di Caserta, abbiamo accettato l’invito della curatrice Isabella Indolfi e realizzato un ambiente transmediale, dove il documentario dialoga con una scultura luminosa e programmata “Memoria sufficiente”, opera frutto di una efficace collaborazione tra me e l’artista sarnese Max Coppetta. La scultura è stata realizzata con una macchina da scrivere Olivetti – M40 progettata tra 1929/30 immersa in una composizione casuale di circa quaranta Olivetti storiche provenienti della collezione del museo Dinamico della Tecnologia “A.Olivetti” di Caserta.
La scrittura luminosa, che viene emessa dai tasti della macchina, è elaborata da una scheda elettronica Arduino, sviluppata all’istituto Interaction Design Institute di Ivrea fondato da Olivetti stesso, e simula una sorta di scrittura priva di alfabeto, un conflitto identitario dell’evoluzione della macchina come celebrazione emotiva del suo superamento.
Il lavoro è pensato in occasione dei 110 anni d’età dell’Olivetti, azienda storica italiana che ha cambiato il destino della comunicazione del nostro paese.
Il documentario si completa attraverso la scultura in una narrazione espansa, uno storytelling non lineare, in cui i contenuti sono sviluppati in funzione alle caratteristiche di ciascun medium, in una narrazione transmediale, che dà la possibilità al pubblico di utilizzare differenti canali di accesso ad un unico tema.
Tu hai un rapporto profondo e confidenziale con Napoli, città in cui vivi da tempo. Napoli è realtà che ha raccontato l’amore in letteratura, in musica, in architettura. Allora ti chiedo: esiste una “lingua dell’amore”? E se sì, ha una cadenza partenopea?
Le lettere del film, o meglio i soggetti protagonisti del lavoro non sono solo napoletani. È un progetto legato al web che ha quindi fatto un viaggio lungo. Attraverso un comunicato, una ricerca di soggetti volontari disposti a raccontarsi abbiamo attratto persone da tutta Europa, una ragazza, Fabiana, è venuta dall’Olanda. Ho poi realizzato un lavoro simile su Napoli ma era importante scegliere un tema universale, in verità un pretesto per incontrare le persone. Il lavoro ha per me un valore autobiografico, personale (ci sono i miei genitori dentro) ma soprattutto relazionale, non contano tanto le lettere ma gli incontri fatti con le straordinarie persone che hanno scritto il film.
 24a Lucania Film Festival · Pisticci · Matera · Southern Italy
24a Lucania Film Festival · Pisticci · Matera · Southern Italy